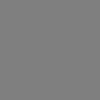| Razionale del corso |
La sclerosi multipla (SM) è la malattia infiammatoria cronica del sistema nervoso centrale più comune nei giovani adulti, con oltre 2,3 milioni di persone affette dalla malattia in tutto il mondo. Questa patologia neurodegenerativa evolve come un continuum con un decorso iniziale recidivante- remittente nella maggior parte dei pazienti, portando gradualmente nel tempo verso una fase di progressivo accumulo di disabilità con o senza attività di malattia, intesa come recidive o nuove lesioni infiammatorie. Circa il 50% dei pazienti sperimenta questa transizione nell'arco di 15-20 anni dall'esordio. Oggi la comunità scientifica non è ancora pervenuta a una definizione universalmente accettata dei criteri che possono indicare con precisione il momento in cui avviene il passaggio da RR a SP e permettere di porre con sicurezza la diagnosi. Questo avviene per una molteplicità di cause, tra cui:
A) L'evoluzione alla fase SP è determinata da un processo fisiopatologico non ancora del tutto chiaro e confuso dalla sovrapposizione di eventi infiammatori e da processi naturali come, ad esempio, l'invecchiamento; questa incertezza ha finora impedito l'elaborazione di marker patognomonici;
B) Da un punto di vista clinico, la progressione è identificata da un aumento della disabilità che dovrebbe quindi essere misurata in modo sensibile e attendibile. Questo non avviene con le attuali scale; la più frequentemente utilizzata, l'EDSS (Expanded Disability Status Scale), presenta infatti diverse limitazioni come l'alta variabilità, la non linearità, la limitata sensibilità e l'insufficiente peso dato a parametri importanti come la funzione motoria degli arti superiori la cognitività. Queste sono le principali ragioni per le quali ad oggi la diagnosi di SPMS è solitamente di natura retrospettiva e si basa sull'identificazione della progressione indipendente dalle ricadute, spesso facendo affidamento ai ricordi del paziente sull'evoluzione del proprio stato di malattia.
Tuttavia, con l'avvento di terapie nuove e altamente efficaci, riconoscere i primi indicatori di progressione della malattia può rappresentare una finestra di opportunità importante per poter intervenire il più precocemente possibile, con l'obiettivo di preservare le abilità fisiche e cognitive dei pazienti, non solo nella fase in cui la SMSP è ancora attiva ma soprattutto nella fase cosiddetta ‘RR transizionale'. Infatti, negli ultimi anni sono state sviluppate terapie che sono in grado di rallentare la progressione della malattia, principalmente attraverso il blocco del funzionamento del sistema immunitario (e.g. siponimod, modulatore recettore S1P).
È stato altresì dimostrato che l'utilizzo nelle fasi precoci di malattia (RRMS) dei farmaci ad alta efficacia si associa a migliori outcomes a lungo termine, anche recentemente. In uno studio di coorte osservazionale che ha utilizzato dati clinici raccolti in modo prospettico, il trattamento iniziale con terapie ad alta efficacia era associato a un rischio significativamente inferiore di conversione a SM secondaria progressiva rispetto al trattamento iniziale con terapie a moderata efficacia. Inoltre, il rischio di conversione era in generale significativamente più basso con il trattamento precoce che con il trattamento tardivo, effettuato entro 5 anni dall'esordio della malattia rispetto all'inizio successivo; anche l'escalation precoce (entro 5 anni dall'esordio della malattia) da una terapia a moderata efficacia verso una terapia ad alta efficacia era associata a un rischio di conversione più basso (Brown et al. JAMA 2019).
Questi dati sono stati confermati da un più recente studio osservazionale sulla disabilità, che ha utilizzato il metodo del propensity-score per confrontare i risultati tra i pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente. Tale studio ha evidenziato che l'inizio del trattamento con terapia ad alta efficacia, entro 2 anni dall'esordio della malattia, è associato a una minore disabilità assoluta a lungo termine e un minor rischio di progressione della disabilità rispetto all'inizio del trattamento 4-6 anni anni dopo l'esordio della malattia (He et al. Lancet Neurology 2020).
Questa premessa ha un'importante rilevanza clinica, infatti l'approccio terapeutico nella SM è guidato, come tutte le aree terapeutiche, dal rapporto rischio/beneficio di ciascun farmaco e, sebbene esista una serie di DMT ad alta efficacia, il loro uso è relegato per lo più a stadi avanzati della malattia o in pazienti con la più alta attività della malattia, poiché il loro profilo di sicurezza o la loro modalità di gestione risulta meno favorevole rispetto alle terapie di I linea a moderata efficacia.
Tali approcci rappresentano un importante passo in avanti per indirizzare l'immunoterapia della SM verso una medicina di precisione, che permetta di colpire esclusivamente le cellule del sistema immunitario diventate patogeniche, lasciando inalterate quelle che svolgono la normale funzione di sorveglianza immunitaria e di protezione dell'organismo. Nonostante le numerose terapie innovative oggi disponibili, sono in corso moltissimi studi in tuttoil mondo per sperimentare nuovi approcci alla malattia, rivolti ad ottenere farmaci più efficaci e con scarsi effetti collaterali, e migliorare la qualità di vita delle persone con sclerosi multipla.
L'obiettivo del progetto, erogato attraverso la piattaforma Neuroflix.it, è quello di coinvolgere e fidelizzare una numerosità importante di specialisti neurologi dedicati alla cura della SM, attraverso una serie di webinar di carattere educativo, formativo ed informativo prodotti da Key Opinion Leaders del settore per arrivare a migliorare l'identificazione precoce del decorso di tipo secondario progressivo; prevenire o rallentare la transizione; trattare in modo personalizzato le forme recidivanti con farmaci ad alta efficacia e sicurezza; approfondire le tematiche del trattamento in corso di family planning, gravidanza e allattamento.
Legenda:
SM: sclerosi multipla
RRMS: sclerosi multipla relapsing remitting
RR: relapsing remitting
SP: secondariamente progressiva
SPMS: sclerosi multipla secondariamente progressiva
DMT: desease modifying therapy
Responsabile scientifico
Dott. Annovazzi Pietro, Dott. Capobianco Marco, Dott.ssa Perini Paola
Board scientifico
Dott. Annovazzi Pietro, Dott. Bucello Sebastiano, Dott. Capobianco Marco, Dott. D'Amico Emanuele, Dott.ssa Perini Paola, Dott. Totaro Rocco, Prof. Matarese Giuseppe, Prof. Puthenparampil Marco, Dott.ssa Lapucci Caterina, Dott. Moccia Marcello
A) L'evoluzione alla fase SP è determinata da un processo fisiopatologico non ancora del tutto chiaro e confuso dalla sovrapposizione di eventi infiammatori e da processi naturali come, ad esempio, l'invecchiamento; questa incertezza ha finora impedito l'elaborazione di marker patognomonici;
B) Da un punto di vista clinico, la progressione è identificata da un aumento della disabilità che dovrebbe quindi essere misurata in modo sensibile e attendibile. Questo non avviene con le attuali scale; la più frequentemente utilizzata, l'EDSS (Expanded Disability Status Scale), presenta infatti diverse limitazioni come l'alta variabilità, la non linearità, la limitata sensibilità e l'insufficiente peso dato a parametri importanti come la funzione motoria degli arti superiori la cognitività. Queste sono le principali ragioni per le quali ad oggi la diagnosi di SPMS è solitamente di natura retrospettiva e si basa sull'identificazione della progressione indipendente dalle ricadute, spesso facendo affidamento ai ricordi del paziente sull'evoluzione del proprio stato di malattia.
Tuttavia, con l'avvento di terapie nuove e altamente efficaci, riconoscere i primi indicatori di progressione della malattia può rappresentare una finestra di opportunità importante per poter intervenire il più precocemente possibile, con l'obiettivo di preservare le abilità fisiche e cognitive dei pazienti, non solo nella fase in cui la SMSP è ancora attiva ma soprattutto nella fase cosiddetta ‘RR transizionale'. Infatti, negli ultimi anni sono state sviluppate terapie che sono in grado di rallentare la progressione della malattia, principalmente attraverso il blocco del funzionamento del sistema immunitario (e.g. siponimod, modulatore recettore S1P).
È stato altresì dimostrato che l'utilizzo nelle fasi precoci di malattia (RRMS) dei farmaci ad alta efficacia si associa a migliori outcomes a lungo termine, anche recentemente. In uno studio di coorte osservazionale che ha utilizzato dati clinici raccolti in modo prospettico, il trattamento iniziale con terapie ad alta efficacia era associato a un rischio significativamente inferiore di conversione a SM secondaria progressiva rispetto al trattamento iniziale con terapie a moderata efficacia. Inoltre, il rischio di conversione era in generale significativamente più basso con il trattamento precoce che con il trattamento tardivo, effettuato entro 5 anni dall'esordio della malattia rispetto all'inizio successivo; anche l'escalation precoce (entro 5 anni dall'esordio della malattia) da una terapia a moderata efficacia verso una terapia ad alta efficacia era associata a un rischio di conversione più basso (Brown et al. JAMA 2019).
Questi dati sono stati confermati da un più recente studio osservazionale sulla disabilità, che ha utilizzato il metodo del propensity-score per confrontare i risultati tra i pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente. Tale studio ha evidenziato che l'inizio del trattamento con terapia ad alta efficacia, entro 2 anni dall'esordio della malattia, è associato a una minore disabilità assoluta a lungo termine e un minor rischio di progressione della disabilità rispetto all'inizio del trattamento 4-6 anni anni dopo l'esordio della malattia (He et al. Lancet Neurology 2020).
Questa premessa ha un'importante rilevanza clinica, infatti l'approccio terapeutico nella SM è guidato, come tutte le aree terapeutiche, dal rapporto rischio/beneficio di ciascun farmaco e, sebbene esista una serie di DMT ad alta efficacia, il loro uso è relegato per lo più a stadi avanzati della malattia o in pazienti con la più alta attività della malattia, poiché il loro profilo di sicurezza o la loro modalità di gestione risulta meno favorevole rispetto alle terapie di I linea a moderata efficacia.
Tali approcci rappresentano un importante passo in avanti per indirizzare l'immunoterapia della SM verso una medicina di precisione, che permetta di colpire esclusivamente le cellule del sistema immunitario diventate patogeniche, lasciando inalterate quelle che svolgono la normale funzione di sorveglianza immunitaria e di protezione dell'organismo. Nonostante le numerose terapie innovative oggi disponibili, sono in corso moltissimi studi in tuttoil mondo per sperimentare nuovi approcci alla malattia, rivolti ad ottenere farmaci più efficaci e con scarsi effetti collaterali, e migliorare la qualità di vita delle persone con sclerosi multipla.
L'obiettivo del progetto, erogato attraverso la piattaforma Neuroflix.it, è quello di coinvolgere e fidelizzare una numerosità importante di specialisti neurologi dedicati alla cura della SM, attraverso una serie di webinar di carattere educativo, formativo ed informativo prodotti da Key Opinion Leaders del settore per arrivare a migliorare l'identificazione precoce del decorso di tipo secondario progressivo; prevenire o rallentare la transizione; trattare in modo personalizzato le forme recidivanti con farmaci ad alta efficacia e sicurezza; approfondire le tematiche del trattamento in corso di family planning, gravidanza e allattamento.
Legenda:
SM: sclerosi multipla
RRMS: sclerosi multipla relapsing remitting
RR: relapsing remitting
SP: secondariamente progressiva
SPMS: sclerosi multipla secondariamente progressiva
DMT: desease modifying therapy
Responsabile scientifico
Dott. Annovazzi Pietro, Dott. Capobianco Marco, Dott.ssa Perini Paola
Board scientifico
Dott. Annovazzi Pietro, Dott. Bucello Sebastiano, Dott. Capobianco Marco, Dott. D'Amico Emanuele, Dott.ssa Perini Paola, Dott. Totaro Rocco, Prof. Matarese Giuseppe, Prof. Puthenparampil Marco, Dott.ssa Lapucci Caterina, Dott. Moccia Marcello
Torna su
X
X